Sylvia Plath, l'arte di morire
Morire è un'arte, come qualunque altra cosa. Io lo faccio in modo magistrale, lo faccio che fa un effetto vero. Potreste dire che ho la vocazione. (Sylvia Plath, Lady Lazarus)
Londra. Fitzroy Road. È la mattina dell'undici febbraio 1963, la poetessa Sylvia Plath sigilla porte e finestre del suo appartamento. Inserisce la testa nel forno a gas e muore asfissiata dal monossido di carbonio.
I suoi bambini dormono nella stanza di fianco. Sui loro comodini c'è del pane imburrato e un bicchiere di latte ma la loro finestra è aperta. A distanza di qualche ora, la governante scoprirà il cadavere, ancora caldo, di Sylvia e il suo ultimo scritto: la poesia L'orlo. Orlo come quel taglio netto, quel confine che stava per valicare, la meta definitiva del suo breve viaggio terreno. Il pensiero della morte ricorre spesso nella poetica della Plath; ha un'ipnotica fascinazione su di lei che la ricerca, la brama tanto affannosamente da rincorrerla, fino a orchestrarla, mettendo in scena il suo suicidio come un atto dovuto, come la chiara ed estrema vocazione della sua vita. Il suo suicidio non sarà un atto isolato ma il fantasma di Sylvia continuerà ad aleggiare. Pochi anni dopo Assia Wevill, donna con cui il marito Ted Hughes l'aveva tradita, si toglie la vita nello stesso modo, portando con sé persino la figlia di quattro anni. Un marchio sanguinario si imprime sulla pelle e nell'anima di chi era stato accanto a Sylvia... anche la sua amica e poetessa Anne Sexton, negli anni Settanta, morì soffocandosi con il monossido di carbonio nel suo garage a Boston. E non è l'ultima. Nicholas Hughes, figlio di Sylvia, fu trovato impiccato nella sua casa in Alaska nel 2009. Sembra quasi una maledizione, un sadico scherzo del destino di quel demone impossibile da mettere a tacere.
Per Sylvia cercare un posto nel mondo non deve essere stato facile; ella avvertiva la dimensione del male di vivere per via della sua acuta ed esasperata sensibilità. Una fragilità di vetro quella della sua anima che esplode nella forza delle sue parole, nelle parole di una donna che cerca di adeguarsi alle convenzioni sociali, quelle dell'America benpensante e perbenista degli anni '50. Sembra non esserci spazio per Sylvia la poetessa che pure avverte un urgente e carnale bisogno di scrivere, tanto che nei suoi diari scriverà:
Ho bisogno di scrivere e di esplorare le profonde miniere dell’esperienza e dell’immaginazione, far uscire le parole che, esaminandosi, diranno tutto….
La sua vita di poetessa, moglie e madre comune procede su un campo minato. Le sue buone intenzioni le fanno da scudo, insufficienti però a proteggerla dal magma incandescente del suo doppio. Alla poetessa fu diagnosticata la sindrome bipolare già da adolescente a causa della quale oscillava fra momenti di febbrile eccitazione e fasi di acuta insicurezza che la portano a somatizzare anche la più insignificante delusione: tutto diviene per lei un ostacolo insormontabile.
Già nel 1953 il pensiero della morte si era fatto incalzante tanto da tentare il suicidio nell'estate dello stesso anno. Dopo aver ingerito una dose massiccia di farmaci, Sylvia si nascose attendendo il sonno fatale. Fu trovata dal fratello due giorni dopo nella cantina della loro villa. Si salvò perché il suo corpo rigettò gran parte della dose letale. Seguì una “cura” a base di elettroshock, descritta nel romanzo semi- autobiografico: “La campana di vetro”. Questa esperienza avrà ripercussioni gravissime sulla sua psiche, Sylvia infatti, qualche anno più tardi in riferimento a questo episodio, dirà: "they pulled me out of the sack, And they stuck me together with glue"; inoltre a seguito egli elettroshock la poetessa infatti dovrà reimparare a leggere e a scrivere.
Nonostante tutto, riesce a laurearsi e sceglie di discutere la sua tesi sul tema del doppio in Dostoevskij. Come lo specchio della sua follia, una proiezione del sottosuolo della sua coscienza. Il suo essere bipolare emerge prepotentemente nelle “Epistole alla madre” alla quale Sylvia dedica sempre parole gentili, nomignoli, vezzeggiativi: cara, carissima, amata, amatissima... eppure sappiamo che il loro rapporto non era idilliaco, anzi... Sylvia le rimprovera una serie di scelte che hanno inevitabilmente contribuito a intensificare il suo tormento e le nasconde quanto la sua vita stia andando a rotoli. Nei Diari personali si manifesta la vera Sylvia: cupa, tormentata, maniaca del controllo e perfezionista sino a risultare ossessiva.
Un corpus letterario ambiguo, se non ci si sofferma a pensare che la maggior parte delle opere della poetessa sono state pubblicate postume. Lo stesso Ted Hughes afferma di aver deliberatamente censurato e distrutto porzioni dell'opera della ex-moglie in quanto riteneva che sarebbe stato troppo doloroso per i suoi figli. Alla luce di questa ammissione, è inevitabile pensare che abbia manipolato e rimaneggiato anche dell'altro. Lo stesso Ted non ne usciva benissimo come uomo e come marito: non solo l'aveva tradita, ma l'aveva anche lasciata insieme ai figli in una condizione economica particolarmente gravosa, senza contare il fatto che fosse pienamente consapevole del tormentato stato mentale in cui versava la ex-moglie. Eppure, il loro, fu un colpo di fulmine. Tutto avvenne nel febbraio del 1956, a Cambridge, dove Sylvia si era trasferita grazie a una borsa di studio. Qualche mese dopo il loro primo incontro, precisamente il 19 aprile 1956, la poetessa scriverà alla madre:
Ti racconterò un fatto miracoloso, strabiliante e tremendo e voglio che tu ci pensi e lo condivida in parte con me. È quest’uomo, questo poeta, questo Ted Hughes. Non ho mai conosciuto niente di simile. Per la prima volta in vita mia posso adoperare tutta la conoscenza, la capacità di ridere e la forza di scrivere che ho, e posso scrivere di tutto, fino in fondo, dovresti vederlo, sentirlo! …È pieno di salute, è immenso…
Il loro matrimonio viene celebrato a giugno di quello stesso anno: lui brillante poeta inglese e lei promettente scrittrice americana sembrano fatti l'uno per l'altra; la loro relazione è quasi simbiotica.
Molte opere nascono infatti dalla comunione di idee, letture, esperienze di quegli anni. Ma il loro è un fuoco di paglia, ben presto si accorgono di essere diversi e la loro relazione inizia a incrinarsi.
Mi manchi come l’inferno. Non posso sopportare di stare con persone che non sono te. […] Grazie a una qualche mistica unione siamo diventati una sola carne; Sono solo malata, fisicamente malata, senza di te. Piango; poso la testa sul pavimento; soffoco, odio mangiare; odio dormire, o andare a letto… Vivo in una sorta di morte in vita...
Quel “gigante” che Sylvia aveva idealizzato esiste solo nella sua testa e su di lui aleggia un'ombra, una delle tante nella vita della poetessa: quella di suo padre Otto Plath. Sylvia infatti si descriveva come una ragazza con il complesso di Elettra, segnata dal non-rapporto intessuto con il padre: professore ipocondriaco, granitico e autoritario, particolarmente distante dalle dinamiche familiari. Egli morì prematuramente a causa di una grave forma di diabete che rifiuta di curare. Eppure dice la Plath nell'elegia: "Daddy" a lui dedicata che se lui non fosse morto prima del tempo, lo avrebbe ucciso lei: Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Salvo poi cadere in contraddizione dicendo che al tempo stesso ha pregato perché si salvasse: I used to pray to recover you. Tutto rientra nella logica non solo della complessità delle relazioni umane ma anche nella diagnosi della Plath: disturbo bipolare con tendenze borderline.
La presenza del padre è altresì soffocante, la chiude in quella campana di vetro che le fa bloccare la voce in gola, ma ancora Sylvia sente la necessità della morte per poter ricongiungersi a lui, dirà infatti At twenty I tried to die And get back, back, back to you. I thought even the bones would do. C'è un'altra espressione particolarmente forte e ambigua in quel componimento: Every woman adores a Fascist, The boot in the face, the brute, Brute heart of a brute like you. Paragonando il padre a una figura violenta, brutale come era quella del soldato fascista ed è qui che prende forma un'ipotesi a lungo contestata: la possibilità che quel pattern e quell'abitudine alla violenza si sia ripercossa ancora una volta nella vita di Sylvia nella dimensione privata e quella pubblica, con Ted e con la società, che ha stigmatizzato le sue fragilità e che non ha accettato il suo “strappo nel cielo di carta”.
Sarà infatti proprio l'ex-marito a scrivere sotto la sua lapide: "Anche fra le fiamme feroci si può piantare il loto d'oro".


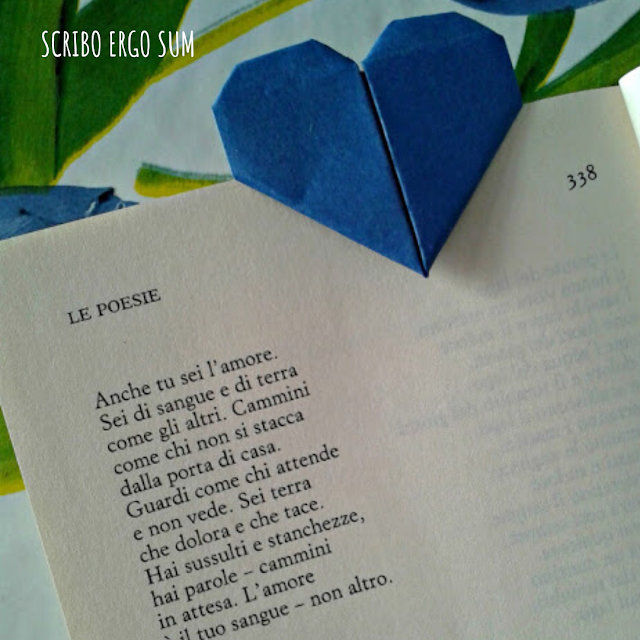

Commenti
Posta un commento